Il Judo tradito - rispondere alle falsità sulla cintura nera e bianca
 |
Pensavo che l’arte di scrivere
cose errate nei fatti e intellettualmente disoneste sul Kōdōkan jūdō affidandosi
a dicerie, manomettendo o ignorando le fonti originali e anteponendo l’ideologia
all’amore per la verità fosse una nostra prerogativa, e con "nostra" intendo "occidentale". Mi sbagliavo di grosso.
Ho letto, tramite segnalazione
di amici, la prima parte della traduzione di uno universitario di Mizoguchi
Noriko, la cui pubblicazione in Italia è in corso sulla pagina del gruppo Kogaku kai, e che invito calorosamente a leggere con attenzione.
Mi pare già di sentire i commenti.
“Ma come, ti permetti di contestare una grande campionessa, una che ha studiato,
una che ha un PhD?”.
La risposta è molto semplice: certo
che sì, se scrive delle fandonie. Non mi interessa chi è che parla, mi interessa
quello che dice. E se quello che dice, sia che si parli di un grande maestro
che dell’ultimo arrivato, non è corretto, è doveroso segnalarlo. Questo perché
sono ligio a un principio che il filosofo Neoconfunciano Wáng Yángmíng sintetizzò
in questo motto: 知行合一 “l’unità di ciò che si sa e ciò che si compie”. In altre parole,
la tua conoscenza implica la responsabilità ad agire. Per inciso, il pensiero
di Wáng Yángmíng era popolare fra i fautori del Rinnovamento Meiji, e anche Kanō
lo conosceva e lo apprezzava.
Sono stupito che non ci siano
più voci a contestare le affermazioni di questo “studio”, che in un’università
seria, o forse in tempi in cui gli articoli universitari dovevano attenersi a
standard di un certo livello, non sarebbe mai stato accettato. Sono stupito, ma
solo fino a un certo punto. Per motivi professionali mi confronto spesso con
ambiti che sono imbevuti di post-modernismo e so per esperienza che ci vuole una
certa dose di coraggio anche solo per manifestare dissenso rispetto al
conformismo dilagante, figurarsi poi contestare qualcosa dati alla mano.
Il Kōdōkan jūdō dovrebbe essere
politica? Immagino di sì, se la intendiamo come cura della polis.
Dovrebbe essere un campo di battaglia ideologico? No. Assolutamente no. Quindi,
senza fare complimenti, ecco perché penso che questo studio sia una vergogna.
1.
TITOLO
L’autrice intitola il suo
lavoro “il paradosso della cintura nera con la striscia bianca”. Perché sia un
paradosso, non ce lo spiega mai.
2.
KEYWORDS
La prima parola chiave dell’articolo
è “gender”. Prima ancora di jūdō, prima ancora di “cintura nera”, che è il titolo
dell’articolo. Ognuno è libero di pensarla come vuole, per carità, ma una
scelta del genere è motivata e mi fa capire subito che non ho a che fare con una
trattazione bilanciata, ma con un testo caratterizzato da un allineamento ideologico deliberato e ben preciso.
3.
ABSTRACT
Questa è la
parte in cui si sintetizza il senso dell’articolo. L’autrice parte subito dalla
constatazione di uno scandalo, la cui realtà e gravità nessuno discute, che ha
coinvolto alcune atlete giapponesi nel 2015. In questo modo si situa il
discorso in un’ottica di “vittimizzazione”, che è il tipico modus operandi di
chi sposa l’ideologia dell’autrice. Poco dopo, ecco una frase completamente
scollegata dall’evento del 2015, eppure illuminante:
“The white-striped Judo black belt
symbolizes the disrespect directed at Japanese women Judo athletes. Foreign
female Judo players wear ordinary black belts ; however, their Japanese
counterparts are compelled to wear black belts with a white stripe. Grading
regulations are identical for men and women in other Japanese martial arts such
as kendo or karate, and women are awarded ordinary black belts just as men”.
“La cintura nera di judo con la
striscia bianca simboleggia la mancanza di rispetto rivolta alle atlete
giapponesi di judo. Le judoka straniere indossano normali cinture nere;
tuttavia, le loro controparti giapponesi sono costrette a indossare cinture nere
con una striscia bianca. I regolamenti di graduazione sono identici per uomini
e donne in altre arti marziali giapponesi come il kendō o il karate, e le donne
ricevono normali cinture nere proprio come gli uomini”.
Da dove cominciamo?
·
il fatto che la cintura nera con la striscia bianca
simboleggi una mancanza di rispetto è una conclusione personale sua, non un
dato di fatto.
·
Le atlete giapponesi non indossano più la
cintura nera con le strisce bianche perché la All Nippon Judo Federation l’ha
dismessa nel 2017. L’articolo è del 2020. Perché l’autrice parla al presente, quindi
come se il fenomeno fosse in corso, di qualcosa che, all’epoca in cui l’articolo
fu pubblicato, era già in disuso da tre anni?
·
Nel kendō non ci sono cinture, quindi alle donne
non vengono “date cinture nere normali esattamente come agli uomini”, e gli
esami di kendō non sono gli esami di Kōdōkan jūdō.
Mizoguchi Noriko è una
campionessa di Kōdōkan jūdō, un’allenatrice, una ricercatrice con un PhD. Devo credere
veramente che un’atleta professionista e una ricercatrice non sappia queste
cose o non sia in grado di trarre una distinzione adeguata tra Kōdōkan jūdō e
kendō?
4.
INTRODUZIONE
L’introduzione
di un articolo che discute di Kōdōkan jūdō e con scelte che il suo fondatore
compì negli anni ’20 si apre con la citazione di una nota autrice femminista
radicale che scriveva alla fine degli anni ’40 in un clima politico, sociale e
culturale diametralmente opposto a quello giapponese, con cui non ha nulla a
che spartire e che di conseguenza non ha i mezzi per interpretare.
“One is
not born, but rather becomes, woman”. These famous words by Simone de
Beauvoir aptly describe the embedded social and cultural gender differentiation
prevailing in patriarchal societies in which men are the preferred first sex
and women form the less important second sex. Similarly, men were the first sex
in Japanese Judo, and women were relegated to second place (Beauvoir, 1949).
«Non
si nasce donna, lo si diventa». Queste famose parole di Simone de Beauvoir
descrivono in modo appropriato la differenziazione sociale e culturale di
genere radicata nelle società patriarcali, in cui gli uomini sono il primo
sesso, quello preferito, e le donne costituiscono il secondo sesso, meno
importante. Allo stesso modo, gli uomini furono il primo sesso nel judo
giapponese, e le donne furono relegate al secondo posto (Beauvoir, 1949).
Può sembrare cosa da poco, ma
il fatto che Mizoguchi Noriko abbia messo la parentesi con il riferimento
testuale alla fine del paragrafo, e non alla fine della citazione, fa sembrare
che Simone de Beauvoir abbia in effetti parlato del Kōdōkan jūdō, cosa che non
ha mai fatto. Inoltre, una rapida occhiata alla bibliografia mostra che Mizoguchi
Noriko ha fatto ampio riferimento a testi di post-modernisti francesi, ma ben
poco riferimento agli scritti del fondatore del Kōdōkan jūdō o dei maestri che
l’hanno seguito. Ad esempio, dalla bibliografia è assente l’opera omnia di Kanō
Jigorō, La Grande Storia del Jūdō Giapponese del 1939, la Storia del Jūdō Mondiale di Maruyama Sanzō, e via dicendo. Non è un handicap da poco,
come vedremo in seguito. Procediamo.
In fact, women were long prohibited from
engaging in Judo. When they were finally accorded the right to play, they were
compelled to sport white‒striped black belts that differentiated them from the male players.
L’autrice inoltre sa, perché è
andata a scuola, che c’è una differenza sostanziale in giapponese tra kubetsu
区別 “distinzione” e sabetsu 差別 “discriminazione”. Il fatto di
avere una cintura diversa, ma dello stesso grado, è in antitesi con le pratiche
culturali del Giappone rispetto alla distinzione, non discriminazione, tra
uomini e donne? Beh…
·
La lingua giapponese varia a seconda che a
parlarla sia un uomo o una donna.
·
I kimono degli uomini sono diversi da quelli
delle donne e indossati in modo diverso. Stesso discorso per gli hakama.
·
Esiste un giorno per i bambini maschi e un
giorno per le bambine femmine.
·
Esistono riti shintō per i bambini maschi e riti
shintō per le bambine femmine.
·
Nell’architettura templare shintō ci sono
santuari “maschi” e santuari “femmina”, (basta vedere Fosco Maraini, l’Agape
Celeste), che si distinguono per la forma di certe decorazioni.
Quindi le
distinzioni, non le discriminazioni, sono semplicemente all’ordine del giorno.
Perché meravigliarsi tanto che Kanō Jigorō avesse stabilito una differenza nell’aspetto
delle cinture è francamente incomprensibile.
White‒striped black belts appear
dimensionally diminished to half their value because of the white line running
through the center of the black belt.
“Le cinture nere con la
striscia bianca appaiono ridotte dimensionalmente a metà del loro valore a
causa della linea bianca che corre al centro della cintura nera.”
Qui l’autrice sta sostenendo che
la cintura nera sembra meno di valore perché c’è meno nero e più bianco. È il
bianco che fa apparire la cintura meno prestigiosa? Eppure, come l’autrice sa
perfettamente, anche la cintura del teorico dodicesimo dan è bianca. Dove è scritto, nello
specifico e precisamente negli scritti di Kanō Jigorō, che la cintura femminile
è concepita in quel modo per far sì che a colpo d’occhio sia meno importante?
Da nessuna parte.
5. L’INTRODUZIONE DELLA CINTURA NERA CON LA
STRISCIA BIANCA
Tutta la sua discussione si
regge sul presupposto che sia sempre tutto, comunque, frutto di una scelta
deliberata a monte concepita con lo scopo di discriminare le donne e
avvantaggiare gli uomini. Che è in buona sostanza il discorso post-modernista di
matrice francese. E a scriverlo è una donna ha praticato Kōdōkan jūdō, è stata
campionessa, allenatrice, e che ha studiato fino al dottorato. Non esattamente la
biografia di un individuo oppresso dalle strutture di potere del patriarcato.
In the Taisho era, the white stripe symbolized schools
for girls. Some people may have felt that the white‒striped black belts signified
disdain for female judokas but others felt that they did not indicate
differences in professional competence but were, instead, merely prettier.
Nell’epoca Taishō, la striscia bianca simboleggiava le scuole femminili. Alcuni potevano aver ritenuto che le cinture nere con la striscia bianca significassero disprezzo per le judoka, ma altri pensarono che non indicassero differenze di competenza professionale, bensì che fossero semplicemente più graziose.
La prima frase è sinceramente incomprensibile. Non c’è nessuna ragione particolare per cui la fascia debba simboleggiare le SCUOLE. Immagino si tratti di un errore dell’inglese.
Su quali fonti si basano
questi “si dice”? Non ci sono riferimenti testuali di nessun tipo, né
citazioni, quindi si tratta o di aneddoti, che hanno ben poco valore
accademico, oppure di conclusioni a priori, che ne hanno ancora meno.
Those who joined the Kodokan women’s club
were upper‒class girls associated with Kano’s normal school or women connected to
political parties. It was estimated that women judokas could be injured in
matches with men. Thus, they were required to wear white‒striped
black belts to distinguish and protect them from harm.
Coloro che si iscrivevano
al club femminile del Kōdōkan erano ragazze dell’alta società collegate alla
scuola normale di Kanō oppure donne legate a partiti politici. Si riteneva che
le judoka potessero ferirsi negli incontri con gli uomini. Perciò fu loro
richiesto di indossare cinture nere con la striscia bianca, per distinguerle e
proteggerle da eventuali danni.
Anche qui, mancano riferimenti
testuali precisi e dunque è difficile valutare su cosa l’autrice basi le sue affermazioni.
È certamente vero che le prime affiliate al Kōdōkan erano di censo
relativamente elevato, ma questo è da inquadrare nel contesto storico dell’epoca:
l’educazione femminile era fortemente incoraggiata, invece che ostacolata, a
ulteriore riprova del fatto che la lettura “patriarcale” del Kōdōkan in particolare e della cultura del Giappone nell’Epoca Taishō in senso lato è una
generalizzazione forzata e imprecisa.
In cosa poi consista l’affronto
di voler distinguere uomini e donne e impedire che ci si facesse male, sinceramente
non lo capisco. Anche questa affermazione, peraltro, non è suffragata da
nessuna nota al testo o riferimento bibliografico.
However, unlike the men’s Judo
organization, the Kodokan women’s club emphasized spiritual training, female
beauty, and etiquette to train women to conform to the Japanese feminine ideal
of Ryo Sai Kenbo 良妻賢母 (good wife, wise mother). This
patriarchal educational ideal encouraged Japanese women to aspire to become
good wives for their husbands and sagacious mothers for the apt nurture of their
children.
Tuttavia, a differenza
dell’organizzazione maschile del judo, il club femminile del Kōdōkan poneva
l’accento sull’addestramento spirituale, sulla bellezza femminile e
sull’etichetta, per formare le donne a conformarsi all’ideale femminile
giapponese di Ryōsai Kenbo 良妻賢母
(“buona sposa, saggia madre”). Questo ideale educativo patriarcale incoraggiava
le donne giapponesi ad aspirare a diventare buone mogli per i loro mariti e
madri sagge per l’adeguata crescita dei loro figli.
Nel corso della mia vita in Giappone
ho avuto la fortuna di conoscere molti maestri e studiare molte cose. Cerimonia
del Tè, Danza Classica Giapponese, Calligrafia, Iadō, Kendō. Ogni singola arte
tradizionale giapponese con finisca con un dō è concepita per affinare l’essere
umano, e di conseguenza, nella prospettiva giapponese, anche per insegnare l’etichetta
e le buone maniere. Sia agli uomini, che alle donne. L’autrice sta, in maniera
straordinariamente disonesta, cercando far passare il messaggio che le buone
maniere fossero solo per le donne. Tra l’altro, di lì a pochi anni, la riforma
scolastica porterà alla nascita della Kokumin gakkō (La Scuola del Popolo), in
cui le ragazze studiavano l’uso del naginata. Quindi tutto il discorso sulla
concentrazione dell’addestramento solo sugli espetti estetici e spirituali cade
immediatamente.
Non solo, ma Kanō scrive
ripetutamente che i kata come l’Itsutsu no kata, il Jū no kata e il Koshiki no
kata hanno un valore artistico affine alla danza, e di conseguenza gli uomini,
che li praticavano, erano essi stessi esposti alla coltivazione della loro
interiorità e della loro sensibilità estetica.
Per non parlare del fatto che
l’ideale della “buona sposa, saggia madre” è un’idea di origine cinese che
andrebbe a sua volta letta ed inserita nel contesto che le compete, che non è
certamente quello dei circoli accademici francesi del ’68. Criticare il passato
in base al presente è un’operazione che riesce bene a chi sposa una determinata
ideologia, ma del punto di vista della ricerca storica serve a ben poco.
At the Kodokan, male judokas were prohibited from
entering the women’s dojo and women never associated with men other than Kano himself or with
leaders designated by Kano. In that period, girls in Japan were prohibited from
playing matches and were thus not accorded the opportunity to rise up the
rankings.
Al Kōdōkan, ai judoka
uomini era proibito entrare nel dōjō femminile e le donne non avevano rapporti
con uomini se non con Kanō stesso o con i dirigenti da lui designati. In quel
periodo, alle ragazze in Giappone era proibito disputare incontri e di conseguenza
non veniva loro concessa l’opportunità di avanzare nei gradi.
A parte l’ormai consueta
mancanza di riferimento bibliografico, che per l’ennesima volta denota una
pratica accademica quantomeno bizzarra, cosa significa esattamente “playing matches”?
L’autrice non distingue tra randori e shiai, e parliamo di un’esperta, il che
mi lascia molto perplesso. Vuol dire che le donne non facevano randori? O non
facevano shiai?
Qual è precisamente il
problema nell’avere spazi riservati alle donne in cui gli uomini non potevano
entrare? Ecco il classico gioco post-modernista e la classica prassi della
vittimizzazione: le donne hanno un dōjō che è riservato a
loro, in cui gli uomini non possono entrare, ma il fatto di avere uno spazio
riservato solo per le donne le vittimizza.
Veniamo alla
questione dello shiai. Se si prende in mano Kanō, sia quello autentico in giapponese
che nelle varie traduzioni, ci si rende immediatamente conto che a Kanō, dello
shiai in quanto tale, importa poco. Anzi, più volte si lamenta che il Kōdōkan jūdō
o i suoi allievi si concentrano troppo sul combattimento e non abbastanza sulla
pratica del kata. Può avere senso allora che gli esami di passaggio di grado
fossero basati proprio su quello che Kanō deplorava, mentre Kanō era ancora
vivo? No.
E infatti,
leggendo i regolamenti del 1920 e del 1927, non c’è scritto che l’avanzamento
di grado è mediato unicamente dallo shiai. Anzi, in un articolo apparso di Jūdō
nel 1918, mette esplicitamente in guardia i jūdōka dal confondere la vittoria
nello shiai con l’avanzamento automatico di grado, e specifica invece che si
deve dare peso al numero e alla qualità delle tecniche conosciute, e alla
comprensione dei principi del jūdō.
Il paragrafo si chiude
con una affermazione che sembra indicare che si faceva apposta a non permettere
alle donne di combattere nei tornei in modo che non potessero avanzare di grado.
Dal momento che si tratta di una decisione ai massimi livelli, l’implicazione è
che fosse Kanō a non voler concedere alle donne la possibilità di acquisire dei
dan. Non c’è nessun tipo di riscontro testuale di nessun genere che autorizzi a
fare un’affermazione simile, specie nei confronti dell’uomo che ha
effettivamente aperto la pratica del Kōdōkan jūdō alle donne, e infatti l’affermazione
non è suffragata da alcuna citazione o riferimento.
Chi ha il libro I
Fondamenti del Judo può andare a controllare l’articolo a p.66 “L'organizzazione
dei Passaggi di Grado” e verificare di persona che lo shiai non era né lo
strumento principale né un elemento indispensabile alla promozione a primo dan,
quindi tutta l’argomentazione sul fatto che le donne non potessero avanzare di
grado perché non potevano combattere crolla immediatamente.
6.
UNO SCONTRO DI JUDO
MISTO PRIMA DELLA GUERRA
L’autrice
descrive il Dai Nippon Butokukai come
A rural organization called Dai Nippon
Boutokukai
Un’organizzazione
rurale chiamata Dai Nippon Butokukai.
Ora, rurale ha un
significato ben preciso. Per essere esatti, il Dai Nippon Butokukai nacque a Kyōto,
che non è campagna bensì la capitale del Giappone per un migliaio di anni prima
dell’avvicendamento con Edo, l’attuale Tōkyō, e non aveva proprio niente di
campagnolo essendo nato per impulso di membri influenti della società, al punto
che al suo vertice venne messo un membro della famiglia imperiale.
Quello che l’autrice
sta cercando di fare è tracciare un falso solco tra il Kōdōkan, accusato di
essere elitario e quindi reazionario e oscurantista in quanto espressione della
borghesia cittadina, e il Butokukai, che in quanto ente rurale era più libero.
Come lo possa fare, sapendo che è giapponese e sa perfettamente che le cose non
stanno così, lo trovo stupefacente.
Per intenderci: il
Dai Nippon Butokukai era nato per preservare e trasmettere la tradizione
marziale (parola chiave: tradizione), sia dal punto di vista pratico che dal
punto di vista etico. Qual era l’etica marziale? Il Neoconfucianesimo, lo
stesso che l’autrice ha criticato letteralmente una pagina fa perché aveva
portato l’idea delle donne come buone spose e sagge madri.
La Storia
giapponese ci mostra che diverse donne appartenenti alla classe dei samurai
furono, in effetti, buone spose, sagge madri, e brave combattenti. Non si
tratta di condizioni mutualmente esclusive. Io personalmente sono sposato con
una discendente di una famiglia samurai e ho sentito direttamente dalla voce della
direttrice dell’Associazione Bushidō queste parole: “se i bushi erano così
valorosi in combattimento, non lo si deve anche al fatto che c’erano delle madri
a crescerli così?”. Di conseguenza, le virtù marziali erano implicitamente ed esplicitamente
patrimonio sia degli uomini che delle donne, e acquisire le une non significava
rinunciare all’educazione, come ben sa chi conosce la massima bunbu ryōdō 文武両道.
È la retorica postmodernista che deve trovare vittime dove non ce ne sono, tracciare
divisioni arbitrarie dove non ne esistono, e leggere qualunque espressione del
rapporto tra esseri umani come un gioco di potere volto alla prevaricazione. Ci
serve questo per comprendere meglio le arti marziali, il Kōdōkan jūdō? No.
Negli ambienti
proni al post-modernismo è invalso l’uso di mettere quelli che si chiamano “trigger
warning”, degli “avvisi” che quello che si sta per ascoltare, vedere o leggere
potrebbe offendere la sensibilità di qualcuno.
Ora a me non
interessa se i fatti offendono qualcuno, ma mi adeguo momentaneamente a una
pratica che non condivido: i fatti oggettivi descritti nel prossimo paragrafo
potrebbero urtare la sensibilità emotiva di qualcuno. Leggete a vostra
discrezione o saltate a quello seguente.
Katsuko Kosaki 小崎甲子defeated three men in five
challenges in the promotion examination match held at the Boutokukai in 1932.
She was the first woman to be placed in the first dan at the Boutokukai. After
this feat, Kano awarded Kosaki the honor of becoming the first woman to be
placed at the first dan in Kodokan.
Katsuko Kosaki 小崎甲子 sconfisse tre uomini in cinque incontri
nella prova d’esame per la promozione tenutasi al Butokukai nel 1932. Fu la
prima donna a essere collocata al primo dan presso il Butokukai. Dopo questa
impresa, Kanō conferì a Kosaki l’onore di diventare la prima donna a essere
collocata al primo dan al Kōdōkan.
Chi ha letto I
Fondamenti del Judo ricorderà certamente un certo articolo “Kodokan e
Butokukai” in cui Kanō Jigorō, il
fondatore del Kōdōkan jūdō, parla del rapporto tra Kōdōkan e Butokukai. Per
completezza, prima di procedere, ricordo che il Kōdōkan è nato nel 1882, il
Butokukai nel 1895, e che Kanō Jigorō era sia il fondatore del Kōdōkan che il
direttore del Dipartimento Jūjutsu del Butokukai. Quindi, comunque la si voglia
mettere, i fatti sono che il Kōdōkan aveva la precedenza, sia dal punto di
visto cronologico che dal punto di vista della legittimazione.
Fatta questa
premessa, nel suddetto articolo Kanō dice:
“[…] Il Butokukai
adottò il Kōdōkan jūdō come metodo educativo, perlomeno nella sede centrale,
affidato a insegnanti che, anche con numerose sostituzioni, non vennero mai designati
al di fuori dei discepoli del Kōdōkan; il che significa che nella scuola Butokukai
si insegna il Kōdōkan jūdō in ogni senso […]
Quindi, comunque
la si voglia mettere, il dato di fatto è che il Butokukai usa il Kōdōkan jūdō,
non un tipo di jūdō diverso. So cosa significa fare un’affermazione come questa
sapendo che in Italia ci fu Abe (con una sola b) Kenshirō e che mosse
determinate critiche al Kōdōkan, ma immagino si trattasse dell’Istituzione, non
della disciplina. Proprio come il jūdō è sempre stato e sarà sempre giapponese,
perché è nato là, da un giapponese, secondo tecniche e principi profondamente
giapponesi, il jūdō è e resterà Kōdōkan jūdō, perché è così che è nato. Il suo
nome è proprio quello.
Procediamo. Rinnovo
l’invito ad approfittare del trigger warning a chi cominciasse a sentirsi
infastidito.
La versione giapponese
dell’articolo è reperibile nell’Opera Omnia di Kanō, Vol.1, p.303. La
traduzione italiana si discosta in una certa misura dell’originale, ma è untema che ho trattato in passato e su cui non mi soffermo qui. Questa è la
trascrizione delle pagine 306 e 307:
講道館においては古くから段制度を設け、級の上に初段があり、それが二段、三段と、十何段でも限りなく進むことになってゐるのである。武徳会の本部で修行してゐるものも、勿論講道館柔道を行ふものであるから、以後は武徳会の教師の申出により、講道館において相当の段に進むることにして、修行者の数も殖え、教師の資格者が漸々増加することになったのである。そのうち、東京の講道館本館に申出できるも、武徳会において段を授けて支部の相談に与り、最後の決定をすることにしたのである。
それも最初のうちは、低い段に限り承認を与えて段を授けることにしてゐたが、後には更に進め、六段以上に当るものも、五段に進むものも、剣道にも段制度を設け、高段に及し、そのうち武徳会においては定めた委員の銓衡によって決定することにしてゐるのである。
今日は移り易く、柔道は大体上の通りであるが、ここに一の問題が生じてきた。それは、最初武徳会が京都で育ったものであったから、特に当時京都においては、講道館の段に無関係に、武道会において道場の認めたとか、また講道館の審議員の意見も聞かずに、むやみに昇段せしめてしまったといふやうな例がしばしば出てきた。
それはもう種々の苦情が生じてきたのである。それをもつと合理的に解決したいものと思つてゐるのである。武徳会さへ同意すれば、段は元来講道館のものであり、教師・範士は武徳会のものであるから、講道館で教師・範士を与えぬやうに、武徳会は段を与えぬことにし、段は講道館のみであるが、武徳会においては、柔道のみならず剣道にも今後それをやめて、異なつた審議機関の申合せによって、各自適当と認める標準によって、勝手に昇段せしむるといふやうなことがあつては、せつかく継続された柔道の階段を破壊することになるのであるから、この弊害を除くことに努力せねばならぬ。
それで、自分は、一面に京都における重なる柔道関係者と、種々解決方につき熟議してゐると同時に、武徳会の会長、副会長としばしば会合して、協議してゐるのである。遠からず、何とかだれしもが満足するやうに解決したいものである。
Al Kōdōkan, da
lungo tempo, fu istituito il sistema dei dan: al di sopra dei kyū vi è il primo
dan, poi si procede a secondo dan, terzo dan, e così via, senza limite, potendo
avanzare anche oltre il decimo dan. Poiché coloro che si addestrano presso la
sede centrale della Butokukai praticano naturalmente anch’essi il jūdō del
Kōdōkan, in seguito, su richiesta degli insegnanti del Butokukai, si stabilì
che avanzassero al corrispondente dan presso il Kōdōkan; così il numero dei
praticanti aumentò, e crebbe via via anche quello dei qualificati come
insegnanti. In quel frangente, pur potendosi presentare domanda alla sede
centrale del Kōdōkan a Tōkyō, si stabilì che fosse il Butokukai a conferire i
dan, a prendere parte alle consultazioni delle proprie filiali, e che la
decisione finale venne presa in tal modo.
Anche questo,
all’inizio, si applicava soltanto ai gradi bassi, si concedeva l’approvazione e
si conferivano dan entro quel limite; successivamente, tuttavia, la pratica si
estese ancora, giungendo a comprendere coloro che avanzavano sino al quinto dan,
persino al sesto dan e oltre. Anche nel kendō fu istituito un sistema di dan,
esteso fino ai gradi elevati, e in tali casi si stabilì che il Butokukai
decidesse in base alla valutazione di commissari da esso designati.
Oggi la
situazione è mutevole, e per il jūdō le cose stanno in sostanza come ho
descritto; ma qui è sorto un problema. Poiché il Butokukai ebbe origine a
Kyōto, avvenne in particolare che allora, a Kyōto, indipendentemente dai dan
del Kōdōkan, si riconoscesse (il dan a un praticante, n.d.T.) nel seno del
Butokukai per semplice approvazione di un dōjō, e inoltre, senza neppure
ascoltare l’opinione dei consiglieri del Kōdōkan, si promuovessero persone in
modo indiscriminato. Tali casi si sono verificati spesso. Ciò ha prodotto
naturalmente ogni sorta di lagnanze. Ho pensato che occorra risolvere la cosa
in modo più razionale.
Se soltanto il Butokukai
acconsentisse a questo: i dan sono in origine del Kōdōkan, mentre i titoli di
kyōshi e hanshi sono del Butokukai. Come il Kōdōkan non conferisce i titoli di
kyōshi o hanshi, così il Butokukai non dovrebbe conferire i dan; i dan devono
appartenere al Kōdōkan soltanto.
Tuttavia, nella
Butokukai, non solo nel jūdō ma anche nel kendō, si è verificata la tendenza a
discostarsi da ciò, e mediante intese di diversi organi deliberativi, a
promuovere a dan secondo criteri che ciascuno riteneva opportuni, a propria
discrezione. Così si distrugge la progressione graduale del jūdō, mantenuta con
tanta cura; di conseguenza, tali abusi vanno rimossi con impegno sincero. Per
questo motivo, da un lato io discuto a fondo con i principali uomini di jūdō di
Kyōto circa i possibili rimedi; al tempo stesso mi incontro e mi consulto
frequentemente con il presidente e il vicepresidente della Butokukai.
Spero vivamente
che, non tra molto, si possa giungere a una soluzione tale da soddisfare tutti.
Questo vuol dire
che il Butokukai non aveva il permesso né il diritto di emettere i dan
indipendentemente dal Kōdōkan, principalmente perché aveva il proprio sistema
di titoli (renshi, kyōshi, hanshi). Kanō è precisissimo: “i
dan devono appartenere al Kōdōkan” proprio perché il Kōdōkan jūdō apparteneva
al Kōdōkan.
Il Butokukai non si
attenne a questa limitazione, come sa chi conosce la vita di Abe Kenshirō prima
di venire in Europa, e di conseguenza questo provocò dei problemi seri nei
rapporti tra Kanō Jigorō e il Butokukai. È per questo, non per colpa del
patriarcato oppressivo, che i dan del Butokukai erano illegittimi. La
dimostrazione migliore ci viene da Abe Kenshirō stesso: quando, in polemica con
il Kōdōkan, tentò di restituire i propri dan, il Kōdōkan rifiutò: non essendo
stato il Kōdōkan a conferirglieli, non poteva accettarne la restituzione.
Giusto per
prevenire possibili fraintendimenti: non sto in alcun modo mettendo in dubbio
la competenza di Abe Kenshirō, la sua legittimità o abilità come insegnante, né
alcun altro aspetto dell’individuo in quanto tale.
L’articolo risale
all’aprile 1932, lo stesso anno in cui Kosaki riportò la sua vittoria nel
torneo del Butokukai. Abe Kenshirō ottenne il 2° dan a 17 anni, nel 1932. Il
lettore può analizzare le parole di Kanō in merito alle azioni del Butokukai
relative all’attribuzione dei dan e trarre le relative conclusioni.
The Butokukai, of which Kosaki was a member, women
were accepted and practiced Judo with men. They were also allowed to test for
promotion to the next level under the same conditions as men.
Nel Butokukai,
di cui Kosaki faceva parte, le donne erano accettate e praticavano il jūdō
insieme agli uomini. Era inoltre loro permesso sostenere gli esami di
promozione al grado successivo alle stesse condizioni degli uomini.
Non c’è nessuna
fonte che confermi l’affermazione di Mizoguchi, tranne Mizoguchi stessa. Al
contrario, c’è abbondanza di prove a sostegno della tesi opposta: il racconto
della prestazione di Kosaki la descrive come un’eccezione, non come la norma.
Il Butokukai aveva la propria sezione femminile e aveva programmi di addestramento
riservati alle donne, quindi sostenere che l’allenamento misto fosse la prassi
è un azzardo non supportato dai fatti.
In 1939, she was designated the first female
Judo Renshi, a title designating an exceptional instructor.
Sono sinceramente
incredulo, e devo per forza immaginare che si tratti di un refuso. L’autrice,
in quanto esperta e in quanto giapponese, non può non sapere che renshi 練士 era in effetti il titolo più basso tra
quelli offerti dal Butokukai, e indica semplicemente qualcuno che è in corso di
addestramento, non un istruttore (kyōshi 教師) né tantomeno un maestro (hanshi 範士). L’errore è così macroscopico che deve essere per forza questo, un
errore. Oppure, come è successo ad altri autori in passato, l’autrice conta sul
fatto che gli occidentali generalmente non parlano giapponese e di queste cose
non se ne accorgono.
Kosaki’s achievements transcended gender differences between men and women and
her title of Judo Renshi became an accomplishment that overturned the gender
concepts of her times.
I risultati di
Kosaki trascendevano le differenze di genere tra uomini e donne, e il suo
titolo di Jūdō Renshi divenne un traguardo che rovesciò i concetti di genere
della sua epoca.
In effetti, con
buona pace dell’autrice, i concetti di genere dell’epoca rimasero esattamente
gli stessi almeno fino alla fine della seconda guerra mondiale, dieci anni
dopo, quindi non si capisce a cosa voglia alludere la frase.
but after Kosaki was promoted at the Boutokukai, the organization was compelled to follow suit and establish a promotion pathway for the Kodokan women’s club.
Ma dopo che
Kosaki fu promossa al Butokukai, l’organizzazione fu costretta a fare lo stesso
e a istituire un percorso di promozione per il club femminile del Kōdōkan.
Qui l’autrice
sostiene che la vittoria di Kosaki obbligò l’organizzazione (cioè il Kanō) a
istituire un modo perché anche le donne venissero promosse. Sembra abbastanza
curioso pensare che si potesse costringere Kanō a gestire la propria
associazione in un determinato modo per via del fatto di avere ricevuto un dan
al di fuori dell’associazione stessa. Ignorando tra l’altro il fatto che la sezione
femminile esisteva già dal 1926 e che non c’è menzione di alcuno scritto di Kanō
in cui egli discuta le proprie intenzioni o i propri progetti per il jūdō
femminile.
At the Kodokan, Noritomi skipped the first dan and
was awarded second dan. This promotion made Noritomi the leading female Kodokan
Judoka ; however, Kosaki was ahead because she had actually won matches.
Al Kōdōkan,
Noritomi saltò il primo dan e fu insignita direttamente del secondo dan. Questa
promozione rese Noritomi la principale judoka femminile del Kōdōkan; tuttavia,
Kosaki era in vantaggio perché aveva effettivamente vinto degli incontri.
L’autrice sta
sostenendo che delle due, Kosaki era superiore a Noritomi poiché aveva vinto dei
combattimenti.
Abbiamo visto che
le regole di promozione del Kōdōkan richiedevano non solo la vittoria in quanto
tale, ma la conoscenza della tecnica e la comprensione dei principi. L’autrice
vorrebbe invece rappresentare l’avvenimento come uno sgarbo a Kosaki e
indicarla come superiore per via del fatto che ha riportato delle vittorie. Il
che è come dire che Saigō Shirō o Tomita Tsunejirō erano superiori a Kanō
perché, a differenza di lui, avevano effettivamente combattuto. E tutto questo mentre
si deplora la deriva eccessivamente orientata al combattimento e alla vittoria
del jūdō maschile. Il ragionamento è assolutamente illogico e in stridente
contraddizione con se stesso, ma riesce splendidamente nel gioco post-modernista
di trasformare qualunque situazione in un insulto, una prevaricazione o una
lotta di potere. A servizio, naturalmente, non della conoscenza o dell’avanzamento
del Kōdōkan jūdō, ma dell’ideologia post-modernista in quanto tale.
7 LA DIFFERENZA TRA LA CINTURA NERA E LA CINTURA NERA CON LA STRISCIA BIANCA
Kano was obliged to introduce a white‒striped black belt at the Kodokan women’s club.
Kanō fu obbligato
a introdurre una cintura nera con la striscia bianca nel club femminile del
Kōdōkan.
Da chi fu obbligato
Kanō, il fondatore e direttore del Kōdōkan? L’autrice non ce lo dice. Lo
afferma e lo lascia alla nostra volontà di crederlo, come la grandissima parte
delle sue affermazioni in questo studio, senza circostanziarlo, spiegarlo, o
dimostrarlo in alcun modo.
The Boutokukai awarded a solid black belt to
women, while the Kodokan’s black belt for women
included a white stripe.
Il Butokukai
conferiva alle donne una cintura nera piena, mentre la cintura nera femminile
del Kōdōkan includeva una striscia bianca.
A parte la
constatazione del dettaglio concreto, in quale misura questo è un problema, e
perché non è più facile spiegarlo con la volontà di distinguere i gradi attribuiti
dal Kōdōkan, sulla base dei propri programmi e dei propri principi, da quelli
che il Butokukai attribuiva arbitrariamente senza consultarsi con il Kōdōkan,
malgrado la disciplina appartenesse nei fatti ai Kōdōkan?
After world war Ⅱ, the general headquarters (GHQ) of The Supreme Commander for the Allied
Powers ordered the dissolution of the Butokukai
Dopo la seconda
guerra mondiale, il quartier generale (GHQ) del Comandante Supremo delle
Potenze Alleate ordinò lo scioglimento del Butokukai.
Questa affermazione
è completamente falsa. È sufficiente controllare il materiale a disposizione
gratuitamente presso la Biblioteca Digitale della Dieta Giapponese per verificare
subito che il Comando Supremo Alleato non dette mai un ordine simile, mentre è
vero il contrario: fu il Butokukai ad autocensurarsi e a sciogliersi in
previsioni di possibili purghe per quei membri che erano stati complici del
regime durante la guerra. Ho discusso e dimostrato ampiamente l’infondatezza di
questa falsa nozione in questo studio:
https://acquautunnale.blogspot.com/2024/10/proibizione-budo-dopoguerra.html
Come risultato,
il Kōdōkan tornò ad essere l’unico ente legittimato ad attribuire i dan, e le
sue regole tornarono ad essere le uniche valide nell’ambiente della disciplina
che da esso era originata, comprese quelle relative alla striscia bianca sulla
cintura femminile. Per l’autrice,
This mandate was confusing and discriminatory
for many female Butokukai judokas, who were now compelled to adopt the white‒striped black belt.
Questo mandato
risultò confuso e discriminatorio per molte judoka del Butokukai, che ora
erano costrette ad adottare la cintura nera con la striscia bianca.
Come possa essere
discriminatoria una regola che vale per tutte indistintamente, non lo riesco a
capire.
8 FEMMINISMO E COMPETIZIONE
According to Kanokogi, some of the Japanese
leaders of the time applied the customs and rules of Japanese society within
the dojo and seemed like dictators“. When the lesson was over,
Sensei ordered his student to drink beer with him. The woman was there as well,
pouring beer. I hated it because I thought it was like Geisha”.
Secondo Kanokogi,
alcuni dei dirigenti giapponesi dell’epoca applicavano nel dōjō le usanze e le
regole della società giapponese e sembravano dei dittatori. “Quando la lezione
era finita, il Sensei ordinò al suo allievo di bere birra con lui. C’era anche
la donna, che versava la birra. Lo odiavo perché pensavo che fosse come una
geisha”.
Ecco l’ennesima
rappresentazione della vittimizzazione ad hoc. Eppure, come gentilmente ci fa
presente l’autrice, si tratta di “regole e costumi della società giapponese”.
Regole e costumi.
Segue un’affermazione
di una ignoranza talmente crassa e patetica da lasciare interdetti. Versare da
bere a qualcuno equivarrebbe ad essere una geisha.
L’autrice,
essendo giapponese, sa perfettamente che per diventare geisha occorrono anni e
anni di durissimo addestramento quotidiano e che, diversamente da quanto
mostrato in un film disgustoso che non cito tratto da un romanzo scritto male e
concepito peggio, la professione della geisha non ha nulla a che vedere con il
sesso. La geisha è una professionista versata in molteplici arti, che gode di
dignità e rispetto. I curiosi possono andare a leggere la biografia Storia di
una Geisha, di Iwasaki Mineko, e vedere come stanno le cose davvero.
Chi si è trovato
a viaggiare in Giappone sa che i più giovani versano da bere ai più anziani,
perché è così che si fa. Non c’è nulla di oppressivo in questo, non più di
quanto sia oppressivo togliersi le scarpe quando si entra in casa, o salutarsi
chinando il capo.
Poche righe dopo,
va ancora meglio.
If anything, the existence of forbidden waza for
women alone spoke to the restriction of waza based on masculine hegemony and
the erotic perspective. Surprisingly, such rules were not revised for over a
decade. Techniques that ostensibly lacked femininity were taboo for women at
that time. These included the Uchi Mata (内股), Ouchi‒gari (大内刈), Kochi‒gari ( 小内刈), and NEWAZA (寝技).
These techniques are now the most popular Techniques among women’s judokas.
In ogni caso, la
presenza stessa di waza proibiti esclusivamente alle donne indicava una
restrizione delle tecniche fondata sull’egemonia maschile e su una prospettiva
erotica. È sorprendente che tali regole non siano state riviste per oltre un
decennio. Le tecniche ritenute allora prive di femminilità erano considerate
tabù per le donne: Uchi Mata (内股), Ōuchi-gari (大内刈), Kōuchi-gari (小内刈) e Newaza (寝技). Oggi proprio queste tecniche sono tra le più popolari fra le judoka.
Qui siamo
veramente a livello da Simone de Beauvoir. Vediamo i fatti.
In quale misura e
su quale criterio uchi mata sarebbe meno femminile di Ōsoto gari? L’autrice non
lo spiega. Dobbiamo semplicemente credere che il problema sia la pruderie del
maschio prevaricatore.
Alcune
precisazioni. Nella mitologia giapponese, il Giappone viene concepito da Izanagi
no Mikoto e Inazami no mikoto, due kami che scendono sulla terra e si cimentano
in un rapporto sessuale dopo essersi sposati ritualmente. Detto in altre
parole: all’origine del Giappone c’è un rapporto sessuale tra un kami maschio e
un kami femmina.
Ci sono feste
tradizionali in cui statue di legno rappresentanti vulve e falli vengono
portate in trionfo da uomini e da donne. E non esistono da ieri: precedono la
fondazione del Kōdōkan di diversi secoli. Fino a non molto tempo fa, le terme
erano miste. Uomini e donne stavano nudi nelle stesse vasche. Le donne a volte
lavoravano nei campi con il petto nudo. C’è una ricchissima e molto variegata
tradizione di stampe shunga 春画 che raffigurano
scene erotiche della natura più fantasiosa. Come coesiste tutto questo con l’idea
che l’egemonia patriarcale abbia costretto le donne a non usare uchi mata in
gara?
9 REGOLE PER LE DONNE GIAPPONESI
Siamo al 1978, l’anno
del primo campionato nazionale giapponese. L’autrice ci dice:
Japanese women were required to wear short‒sleeved white round‒neck shirts, sport a white‒
striped black belt, and tie long hair.
Alle donne
giapponesi era richiesto di indossare magliette bianche a maniche corte con
scollo tondo, portare la cintura nera con la striscia bianca e raccogliere i
capelli lunghi.
A parte la
cintura, quale sarebbe il problema di avere i capelli raccolti e di indossare
una maglietta sotto il jūdōgi non ci viene spiegato, ma viene presentato come
una cosa che agli uomini non è richiesto. Probabilmente per via delle evidenti
distinzioni anatomiche tra il torso maschile e quello femminile.
Questo però è il
meno. Ecco un passaggio più saliente:
In Yamaguchi’s opinion, the game rules for women imputed the male desire for
aggression onto women. She felt that the rules insulted all female judokas
because prohibitions such as“ Don’t grab opponent’s hair” were meant only for women.
According to her, all judokas, regardless of whether they were male or female,
knew not to grab their opponent’s hair even if it was not
specifically banned. Yamaguchi thus felt that the rules were generated out of a
male perspective of what could be expected from women and were thus demeaning.
Secondo
Yamaguchi, le regole di gara per le donne attribuivano alle donne il desiderio
maschile di aggressività. Ella riteneva che le regole offendessero tutte le
judoka perché divieti come “non afferrare i capelli dell’avversaria” erano
intesi solo per le donne. A suo avviso, tutti i judoka, indipendentemente dal
fatto che fossero uomini o donne, sapevano di non dover afferrare i capelli
dell’avversario anche se ciò non era specificamente vietato. Yamaguchi ritenne
dunque che le regole fossero generate da una prospettiva maschile su ciò che ci
si poteva aspettare dalle donne e fossero quindi umilianti.
La Yamaguchi, e la
Mizoguchi di conseguenza, sicuramente non possono non sapere che una esplicita
proibizione circa l’afferrare in capelli era già parte del regolamento maschile
nel 1960. Il Regolamento del Kōdōkan jūdō per i Combattimenti dice che fra gli
atti proibiti vi sono
「相手の髪の毛をつかむこと」 L’afferrare i capelli dell’avversario.
Una posizione
identica si trova nel regolamento dell’International Judo Federation del 1967.
Quindi, è
evidente che la menzione della proibizione di afferra i capelli non è, come afferma
erroneamente la Yamaguchi, il risultato della “prospettiva maschile” su ciò che
ci si può aspettare dalle donne, ma è esattamente ciò di cui l’autrice lamenta
l’assenza: l’estensione anche alle donne delle medesime regole degli uomini.
10 CONCLUSIONI
E siamo ai punti
finali. Dopo avere passato quasi tutto lo studio a spargere assunti aprioristici
e conclusioni arbitrarie come se fossero dati di fatto inoppugnabili, l’autrice
afferma:
A further reason that Kano prohibited matches in
women’s judo may have been an
interest in creating “judo as play” (women’s judo) through kata and melees as an antithesis to matches (men’s judo).
Un’ulteriore
ragione per cui Kanō proibì gli incontri nel jūdō femminile potrebbe essere
stata l’interesse a creare un “jūdō come gioco” (jūdō femminile) attraverso i
kata e le risse, come antitesi agli incontri (jūdō maschile).
Adesso si tratta
di “may”. “potrebbe”. Poi, c’è una notevole e curiosa mancanza di precisione
nel differenziare shiai e randori. L’autrice parla di matches, e melees, quindi
è difficile stabilire a cosa esattamente si stia riferendo.
Kano is also said to have spoken of “kata” as grammar and“ matches” as essays (Noritomi,1972).
Si dice anche che
Kanō abbia parlato del “kata” come della grammatica e degli “incontri” come dei
saggi (Noritomi, 1972).
Qui c’è un’altra
inconcepibile (a mio avviso) dimostrazione di completa mancanza di metodo e di
rispetto per il lettore. Gli scritti di Kanō sono nella stessa lingua dell’autrice.
Basta veramente poco per andare a verificare cosa Kanō abbia o non abbia detto.
Non si può, o meglio non si dovrebbe, usare una fonte secondaria invece di
citare direttamente le parole esatte di Kanō, non in qualcosa che lo riguarda
così da vicino.
Prewar, the Kodokan women’s division constituted women’s physical education for daughters of the Tokyo upper
class as a part of“ good wife, wise mother” education,
with no matches being held. In contrast, the women of the Butoku Kai were
primarily from the provincial middle class, taking part in judo in a liberal
atmosphere with matches and melees held regardless of gender.
Prima della
guerra, la sezione femminile del Kōdōkan costituiva l’educazione fisica
femminile per le figlie dell’alta società di Tōkyō come parte dell’educazione
di “buona sposa, saggia madre”, senza che si tenessero incontri. Al contrario,
le donne della Butokukai provenivano principalmente dalla classe media
provinciale e praticavano jūdō in un’atmosfera liberale, con incontri e scontri
che si svolgevano senza distinzione di genere.
Qui l’autrice
vorrebbe convincerci che il Kōdōkan fosse al servizio dell’ideologia oppressiva
che voleva trasformare le donne unicamente in buone sposa e madri sagge, mentre
il Butokukai era un’istituzione liberale in cui le donne si allenavano insieme
agli uomini.
Questo è un
rovesciamento completo e intellettualmente disonesto della realtà. Primo, il Kanō
aveva concepito il Kōdōkan jūdō perché fosse ideologicamente neutro, in modo
che chiunque potesse praticarlo, e nessuno dei suoi scritti dice, né
esplicitamente né implicitamente, che il jūdō femminile serve a trasformare le
donne in buone spose e sagge madri. Questa era certamente l’aspettativa dell’epoca,
ma si tratta della cultura giapponese, maschile e femminile, di quell’epoca,
non della volontà di Kanō o di una decisione deliberata del Kōdōkan. Secondo,
il Butokukai era a tutti gli effetti una istituzione collegata al governo e
pienamente coinvolta nella diffusione dell’ideologia militarista, quindi
sostenere che la sua atmosfera fosse liberale è una sciocchezza. In aggiunta,
come abbiamo visto, Kosaki fu l’eccezione, non la regola, di conseguenza è
scorretto e fuorviante cercare di convincere il lettore a credere che l’allenamento
misto al Butokukai fosse la prassi.
E infine, il
colpo di grazia.
Because the Butoku Kai “( Martial Virtue Society”) and kosen (technical college) judo had
collapsed after the war, a myth became established and accepted, with Kodokan
judo coming to represent“ legitimate judo” and the Butoku Kai and kosen judo as“ heretical judo”.
Poiché il Butokukai (“Società della Virtù Marziale”) e il jūdō dei kōsen (scuole tecniche
superiori) erano crollati dopo la guerra, si affermò e venne accettato un mito,
secondo cui il jūdō del Kōdōkan rappresentava il “jūdō legittimo”, mentre il
jūdō della Butokukai e quello dei kōsen erano considerati “jūdō eretico”.
Secondo l’autrice,
il fatto che il Kōdōkan jūdō sia il jūdō legittimo sarebbe un mito. Nonostante
Kanō, come abbiamo visto, abbia scritto esplicitamente che anche il Butokukai
usava il Kōdōkan jūdō, e dunque anche quello del Butokukai era Kōdōkan jūdō.
Nonostante il Kōdōkan fosse nato prima del Butokukai e nonostante Kanō, non il
Butokukai, avesse sviluppato il jūdō. Tra l’altro, il Kōsen jūdō ha tutt’altra
derivazione, quindi associarlo al Kōdōkan jūdō e al Butokukai non ha molto
senso.
C’è da rimanere
interdetti. Come si fa a pubblicare una cosa del genere senza che nessuno protesti,
senza che nessuno dica nulla? Dov’è il tanto vantato rispetto per Kanō Jigorō e
per la sua “creatura”, come la chiamano alcuni? Per i suoi principi e i suoi
valori? Per la Storia vera, non per le fandonie confezionate ad arte per portare
acqua al mulino di questa o di quella corrente ideologica?
Lo studio in
questione ignora sistematicamente le fonti storiche, manipola concetti e avanza
affermazioni prive di documentazione. Non si tratta di semplici imprecisioni: è
una pratica che, quando rivestita di veste accademica, produce mistificazione e
non conoscenza.
È un dovere
denunciarlo. Non soltanto per rispetto della verità storica, ma anche per
rispetto verso Kanō Jigorō, il fondatore del Kōdōkan, che con i suoi scritti e
le sue azioni ha reso possibile anche alle donne l’accesso al jūdō.
Che affermazioni di questo genere siano state pubblicate in ambito universitario senza contestazioni è sintomo di un problema strutturale: il conformismo ideologico che antepone un’interpretazione precostituita alla verifica dei fatti. Lasciare che questo avvenga significa tradire non solo la memoria di Kanō, ma il principio stesso su cui il Kōdōkan jūdō si fonda: la ricerca sincera della verità attraverso lo studio e la pratica.
Emanuele Bertolani
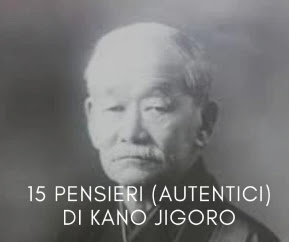
.png)
Commenti
Posta un commento
La tua opinione è preziosa per noi. Grazie del tempo che ci hai dedicato.